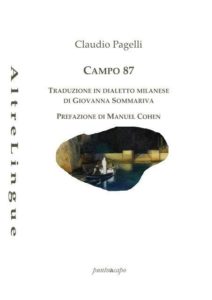‘CAMPO 87’ DI CLAUDIO PAGELLI
Campo 87 (Puntoacapo) – titolo della nuova raccolta poetica di Claudio Pagelli (Como, 1975) – fa riferimento al comparto, in seno al Cimitero Maggiore di Milano, dove sono state interrate molte persone decedute a seguito della pandemia del Coronavirus, corpi riferiti, nella maggior parte dei casi, a persone che non avevano cari né familiari. Si tratta di un’opera poetica bipartita, per linguaggi, dal momento che Pagelli ha deciso di proporla anche in dialetto milanese – sulla tradizione aulica del dialetto lombardo che da Porta transita per Tessa e conduce a Franco Loi, recentemente scomparso – con, a fronte, il testo in lingua nazionale. La versione in dialetto meneghino è curata da Giovanna Sommariva (Saronno, 1948) mentre le note critiche incipitarie sono di Manuel Cohen; quest’ultime – in particolare – si apprezzano perché aiutano ad avvicinarsi all’opera di Pagelli e, addirittura, a meglio comprenderla. L’amministrazione del capoluogo meneghino ha deciso, nel tribolato anno 2020 nel quale la pandemia ha falciato un gran numero di vite, di dedicare un’apposita sezione del Cimitero Maggiore di Milano, noto anche come Cimitero Musocco, a coloro che se ne sono andati nel silenzio, privi di affetti, amici, che hanno lasciato questa terra in una situazione di completa solitudine. Operazioni di questo genere non rimangono mai sotto tono e, infatti, hanno aperto in taluni casi, a delle polemiche ma l’Assessore ai Servizi Civici del Comune di Milano, la dott.ssa Roberta Cocco – intervistata sull’argomento – ha rivelato: “Ci sembrava doveroso dare una sepoltura dignitosa a queste persone. Si tratta di persone che non hanno famiglia, o che addirittura avevano a loro volta i parenti in ospedale per Covid-19. In questi giorni i media hanno parlato di “fossa comune”, ma questo termine è scorretto, perché a ognuno di questi morti abbiamo cercato di dare singolarmente una tomba”. Questi i fatti. Claudio Pagelli fa di questo episodio di cronaca – testimone di un’annata indecorosa per la vita di tutti, dettata da lutti, impoverimenti e scalfitture gravi al proprio senso d’autostima, il motivo trainante della sua opera letteraria. Ed ecco che nei versi che si susseguono nella raccolta si percepisce un’aria dolorosa del recente lutto, condiviso da tanti nostri simili, pianto da tante famiglie italiane, si procede, verso dopo verso, allegoricamente come passeggiando con riserbo e un senso generale d’incomprensione su quanto accaduto tra gli stradelli campestri di un cimitero vasto. L’aria crepuscolare, il motivo cimiteriale che si lega a quello dell’esigenza di memoria, sono dei capisaldi dell’intera “narrazione”, per immagini, in una desolata Spoon River contemporanea dove, dinanzi a tante esperienze sfumate, sembra quasi perdersi il senso di ogni cosa. I versi d’apertura che contraddistinguono l’esergo non potevano non essere tratti da uno dei capostipiti della lirica resistenziale e sepolcrale al contempo, l’americano Edgard Lee Masters (1868-1950), cronista attento e sensibile di un mondo perso e in progressiva perdita, testimoniato da segni fugaci e miserevoli di un passaggio avvenuto. Con l’opera di Pagelli viene richiamata, per rimando letterario ma anche per associazione d’immagini e di tòpoi, tutta la tradizione cimiteriale che nella poesia romantica inglese ha forse visto il suo acme in James MacPherson (1736-1796), con la relativa poesia ossianica che da lui prese avvio, senza dimenticare la – di poco precedente – presenza di Edward Young (1683-1765) e, nel nostro Paese, degli intellettuali Ugo Foscolo (1778-1827) e Ippolito Pindemonte (1753-1828). Sebbene il motivo fondamentale che Pagelli in qualche in modo insegue è quello di tracciare la gravità e la desolazione che sono dilagate nel contesto meneghino (dappertutto nel mondo, è vero, ma qui il dettaglio, la specificazione di sorta, diviene emblema di un riferimento che tende all’universalità, al mondo intero che ha sofferto drammi analoghi) a causa del grave morbo virale che ha stravolto le nostre vite, predisponendoci a una diversa maniera d’affrontare i problemi e la vita, rendendo impellente quel dialogo con noi e l’alterità precedentemente dato per assunto, palese, fintanto banale e, invece, riscoperto come esigenza di primaria ascesa, è anche vero che contenutisticamente ci troviamo dinanzi a dei veri burial poems, brani di quella tradizione cupa e meditabonda, sofferente e psicologicamente instabile, dettata dalla miseria e dal dolore, di secoli fa. Attenzione va posta alla conformazione strutturale dei versi di Pagelli; lo stesso Cohen ha osservato: “Si tratta di piccole strutture strofiche, brani, lacerti, schegge lirico-narrative che tanto assomigliano a piccoli sedimenti tra polvere e zolla, nuclei germinali di narrazioni o plot, e a epitaffi tombali, in cui a dire, a raccontarsi, è la voce stessa delle vittime” (6). Molta della poesia funebre è stata in passato celebrativa, assumendo tratti magniloquenti ed enfatici, quando non addirittura encomiastici e sfegatati, atti a innalzare il personaggio – buono o meno – che, trapassando a miglior vita – per ragioni di vario tipo o di sudditanza – non poteva non essere pianto e celebrato. Si pensi alla poesia risorgimentale o, più in generale, patriottica. Non è questo il caso: qui non si piange il personaggio che ha reso grande un Paese, un letterato, uno scienziato, ci si allinea a un dolore comune, che è quello del popolo, della classe borghese, ma diremmo dell’umanità tutta che è stata scossa duramente da una tragedia che, per certi versi, ha toccato tutti noi. Non un carme identitario di dolore, un pianto pensato con un destinatario specifico, ma un intero campo, appunto, a raccogliere la considerazione, il pensiero, semmai la preghiera nostra e di chi, con empatia, ha vissuto questa vicenda dell’esperienza tangibile da vicino, in maniera personale. Si tratta di un dolore collettivo, di un’assenza generalizzata ma non per questo meno sentita all’interno della propria anima; Pagelli è il ricettore attento di questo senso di svuotamento dell’uomo contemporaneo dinanzi agli accadimenti che l’uomo non è riuscito ad evitare, testimone non tanto della tragedia, ma delle venature a tratti insondabili del dolore umano, del disagio, dell’incapacità di dire, di quel morbo atavico della depressione e dell’angoscia, fugata – per fortuna – da tracce lievi ma pur valide di resilienti animi e di speranza rinnovata. Ed ecco alcuni estratti dell’opera di Pagelli; per rendere facilmente fruibile la comprensione a tutti, citiamo direttamente dal testo in italiano, sebbene – come spesso avviene col dialetto – la forza di alcune immagini e la tensione emotiva e lirica in questo idioma primigenio in alcuni punti sembrano senz’altro più incisive e pregnanti della lingua codificata. Ci sono immagini che trasmettono l’ammutinamento e la presa d’atto della condizione inerte dell’umanità: “Tutto si prende questo grande silenzio” (10) a cui si associa la condizione di marginalità e solitudine di molte di quelle persone che, morendo, se ne sono andate nel silenzio e nell’assenza di affetti: “invisibile lo sono sempre stato” (44) sostiene uno di essi. Pagelli è come se passeggiasse idealmente tra le tombe che costituiscono il campo 87 e sentisse le voci di quelle anime, vogliose di raccontarsi, di perpetrare la propria presenza sulla terra, di reclamare l’ascolto e la vicinanza che in vita non hanno avuto. Questo avviene mentre, come dice un altro con un tono compassato, “il mio corpo si sfarina” (34). Un altro è convinto che la morte non è che la dimenticanza ultima e completa di un’esistenza laterale, innocua, tendenzialmente ai margini e isolata: “Dei nostri corpi sepolti, dei nomi / degli uomini, nessuno dirà” (66). I morti che prendono la parola non sono una novità assoluta nella letteratura. Ma qui c’è qualcosa di diverso: sappiamo che quei morti non sono mera finzione dell’autore ma esseri reali, nostri potenziali vicini, nostri potenziali conoscenti. Ecco, allora, che il Poeta non può non eludere le loro voci, non può far finta di non sentire quegli afflati, la sua coscienza gli impedisce di non dar testimonianza, e dunque, seguito a quei messaggi di strazio, di sofferenza, di interdizione, ma anche di accettazione remissiva dinanzi ai misteri della vita. Uno di essi, rievocando l’eziologia del Male che l’ha intaccato, dice: “Credevo fosse solo tosse / […] / Ho spento tutto, anche la televisione, / e ora eccomi, al camposanto, / in un guscio di larice” (18); gli fa eco altre persone: “il veleno nell’aria, l’aspra primavera…” (54); “Me ne sono andato in una febbre / in una tosse irrisolta del mondo” (58) e poi ancora: “questo veleno / arpia d’aria, giaguaro…” (72). L’idea della morte per asfissia, per difficoltà respiratoria, quale oppressione insostenibile ritorna in vari altri testi a descrivere con vividezza il dramma di tante persone che così hanno combattuto le ultime ore di vita: “Nelle pieghe dei polmoni / s’è nascosto il veleno. / Respirato non so dove” (40); “Così difficile respirare / su quel letto d’ospedale – / di pietra i polmoni / immobile il corpo / un tubo giù in gola – / qui dove non conta la carne / sono d’aria le ossa, leggeri i miei passi…” (76). Il tono di questi morti che vivono nella testimonianza delle loro ore buie non è dettato da ira, è parco e sembrerebbe quasi pacificato; viene espressamente evitato un linguaggio che faccia uso di sproloqui, che inveisca, teso a maledire e condannare. Al contrario c’è una rilassatezza nel dire che proviene, forse, dalla rivelazione della luce nella quale ora abitano: “È trascorsa la mia vita / come un’ombra / […] / una parentesi di vetro” (24). Nel nuovo spazio che dimorano, nel campo 87, è appiattita – e per sempre – quella distanza sociale, quel senso d’isolamento dal mondo, la marginalità, l’anaffettività sociale. Sono tutti fratelli che si mescolano alla terra, non più miserie umane e difficoltà economiche: “Non avevo nulla / […] / Case di cartone / […] / Adesso, almeno, non temo la tempesta / con un ombrello di terra sopra la testa…” (32).