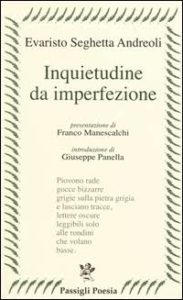IL SOGNO DELLA TOTALITÀ IN EVARISTO SEGHETTA
La lirica di Evaristo Seghetta Andreoli è una poesia fatta e campita di aspirazioni, dato che la sua cifra profonda, quella che paradossalmente affiora meglio alla superficie del suo dettato poetico, nasce dalla ricerca di un qualcosa di impossibile (e ben noto come tale a chi vi si avventura) che purtuttavia si insegue e si prova a rappresentare con parole che sono certo inadeguate allo scopo ma che, perseguendolo comunque, colgono sempre un bersaglio, raggiungono un obiettivo, si fanno carico di un destino e di una vita che vuole la scrittura come proprio nume tutelare. Non è un caso che la nuova silloge poetica si intitoli Inquietudine da imperfezione (Passigli), a sottolineare la natura di non-raggiungibilità dell’obiettivo che si prefigge, l’impossibilità di arrivare a una conclusione definitiva, la necessità di continuare sulla strada da lui imboccata di una poesia fatta di volontà di verità e intrisa profondamente di desiderio. La storia stessa della formazione di Seghetta Andreoli, come lui stesso la racconta in una sorta di breve avant-propos, è assai significativa. Uomo di letture disparate ma che confluiranno poi alla fine in un unico progetto di scrittura, curioso e a proficue immersioni in una cultura letteraria in cui predominavano i classici della letteratura italiana (Dante, Foscolo, Manzoni, Carducci) ma anche autori contemporanei e comunque assai più recenti (Calvino, Ungaretti, Cassola, Pavese, Buzzati, Malaparte) o poeti della tradizione simbolistica ottocentesca (Verlaine e Baudelaire, tanto per fare un esempio come pure, su tutt’altro versante, l’Edgar Lee Masters della Spoon River Antology) o i cantautori della scuola italiana degli anni Sessanta come De Andrè o Guccini (insieme a cantanti più commerciali come il pur mitico Lucio Battisti), Seghetta Andreoli si è concesso una lunga attesa prima di cominciare a scrivere testi autenticamente rivissuti e rivisitati sulla base di quelle stesse professioni di fede letterarie. Il suo punto d’approdo rappresenta, quindi, la conclusione (si spera ovviamente solo provvisoria) di un lungo cammino, di una strada intrapresa negli anni della formazione scolastica e continuata con pertinacia e pervicacia nel corso del tempo e delle sue vicende personali individuali. Nel suo libro precedente, I semi del poeta del 2013, la ricerca dell’autore era rimasta maggiormente confinata all’interno di un recinto di lettura poetica più intimo, del tutto personale, aperto a squarci e a lampi di rappresentazione della vita del presente ma assai meno propenso a sfondare quel confine della comprensione di sé composto dallo scavo interiore delle proprie contraddizioni e di riproposizione di letture e di eventi individuali. In quel primo progetto di versificazione compiuta, Evaristo Seghetta Andreoli, che è sempre rimasto funzionario di un istituto di credito di Arezzo per scelta di mestiere (come è accaduto a molti altri suoi illustri predecessori, tra i quali basterà ricordare Thomas Stearns Eliot, impiegato nel 1915 presso la compagnia assicurativa dei Lloyds di Londra o il romanziere Giuseppe Pontiggia) si rivelava fin da subito poeta lirico per sincera dedizione alla pratica della scrittura. Lo si poteva facilmente dedurre dalla passione con cui si era gettato nella stesura dei versi di questo suo primo libro di versi. Come ha scritto Patrizia Fazzi nella sua breve ma molto intensa prefazione al volume, il poeta si era realizzato finora solo nella profondità della sua applicazione continuata alla pratica assidua del verso e alla sua volontà di portarla avanti a qualsiasi costo: “Evaristo Seghetta Andreoli, quasi novello Italo Svevo, pur se calato, come l’autore triestino, nelle stanze dei conti e dei rapporti commerciali, ha mantenuto il ‘vizio’ segreto di scrivere, di annotare e trasformare in poesie l’esercizio altrettanto quotidiano di ascoltare se stesso e di ‘osservare’ la realtà esterna e i fenomeni naturali nella loro mutevole misteriosa epifania”. Ma la poesia di Evaristo non era in quel primo tentativo soltanto un «giornale di bordo» dell’Io e un’evocazione in versi di eventi quotidiani che si rastremavano in una voce che cantava o sussurrava utilizzando le parole più adatte a decantarli; era sostanzialmente e fondamentalmente un omaggio alla poesia come ragione di vita, come «seme dell’uomo» e della sua necessaria vocazione al superamento della quotidianità in nome di un Oltre necessario. È quello che si può ritrovare compiutamente in molti dei suoi testi più suggestivi legati alle letture di formazione del loro autore (e di cui si diceva prima). Sono «i semi» dell’Universo, gli atomi immortali e cangianti della tradizione epicuraica e lucreziana, che il clinamen che li guida spinge a congiungersi continuamente e ostinatamente per realizzare quel mondo in cui viviamo e che continuamente si compone e si ricompone in un intreccio assoluto e pur sempre transitorio, fatto di eternità e di silenzio. Allo stesso modo, si ricompone e si ricostituisce la dimensione poetica più significativa di Seghetta – le parole si intrecciano, si annodano, si separano, si ricongiungono, si riconnettono e si rinnovano continuamente, utilizzando i pre-testi più labili per trasformarli in momenti che aspirano all’eternità. A questo modo, le città in cui Seghetta ha amato o è vissuto o in cui ha lavorato (Parma, Ferrara, Orvieto, una Carrara rivissuta assai efficacemente come «vela di marmo», città lontana e contemporaneamente ricca di suggestioni musicali), le situazioni poetiche più frequentate (la pioggia, l’alba, l’amore contrastato o vittorioso), la cultura del passato che non si rifiuta all’attraversamento di una modernità mai esaltata in maniera astratta ma pesata e pensata in modo tale da saggiarne la portata universale, la passione e i sentimenti della vita che permettono alla poesia di porsi sullo stesso piano delle necessità dell’esistenza e di redimerle, costituiscono la sostanza del debutto di un poeta che ha scelto la scrittura per verificare la verità profonda della propria vocazione. Nel suo esordio da poeta «scritto» e pubblicato, l’apprendistato naturale del poeta si scioglie in un avvolgimento di carattere musicale di classica evidenza e si sposa all’aspirazione a darsi ragione del mondo attraverso la sua descrizione in termini concretamente connessi all’esperienza rivissuta attraverso il filtro della tradizione letteraria. Nel suo secondo libro (un libro della piena maturità – va detto fin dal principio) non si è più in presenza del Classico ritrovato che aveva contraddistinto il testo precedente. Non che Seghetta abbia scelto la strada dello sperimentalismo più outré o di una ricerca che cancellasse le tracce della sua amata formazione giovanile, tutt’altro. Ma le sei sezioni che compongono il nuovo volume di liriche sono ora ricondotte a un disegno unitario, al sogno di una totalità, al desiderio di dare un senso non solo alla vita fino ad allora trascorsa quanto allo scrivere poesia come sentimento onnipervasivo del tempo. Nel testo che apre la raccolta e che porta lo stesso titolo generale che illustra il libro, le intenzioni generali del poeta sono esposte con chiarezza onirica. L’aspirazione del poeta è qui palesemente rivolta alla Totalità che fuoriesce dalle coordinate categoriali di spazio e tempo, alla ricerca di una sintesi impossibile ma sempre desiderata come potenzialità suprema e che lo porta a cercare di ricongiungere materia e pensiero, il pieno delle cose esistenti al vuoto dello spazio siderale, il movimento frenetico della realtà alla statica eternità di ciò che riposa nella verità assoluta dell’Essere, ciò che non esiste più a ciò che sarà vivente in futuro. Il progetto sperato e ambito è quello di fuoriuscire dalle sottili pareti dell’Io, di attingere a verità che siano durature e universali, di fuggire all’assurda verità che lega a un presente condizionato dalla necessità di aderire all’esigenza «opprimente» dei bisogni individuali mentre si vorrebbe ritrovare in se stessi e nel mondo i «fiori prediletti» di ciò che è eterno e che la vita si ostina a confinare nel recinto impassibile della transitorietà della sequenza di nascita e morte. La poesia per Seghetta è dunque (lo ammette lui stesso!) l’alfa e l’omega dell’esistere consapevole e cosciente, la ragione stessa dello scrivere che si configura come possibilità del vivere autentico e libero dalle strettoie del contingente, dove nella tristezza legata allo scorrere imperterrito della vita (il modello rappresentato dalla clessidra e del suo ruit hora di classicistica ascendenza) e nel passaggio tra notte e giorno come simbolo imperterrito della caducità dell’esistenza e del suo eterno rincorrersi alla ricerca di qualcosa che alla fine non sarà mai ritrovata nella sua interezza così come non sarà mai possibile ritrovare la luna che si è persa nel pozzo e che invano si cerca di afferrare con le proprie mani fallibili di uomo, è purtuttavia rintracciabile l’elogio finale dell’Io come unico punto di riferimento praticabile. «Inquieto e imperfetto» eppure «magnifico» è l’Io che annoda l’inizio alla fine, la ricerca alla sua finalità, il sogno al suo destino, il desiderio al suo oggetto imprendibile. La «magnificenza» del finito consiste proprio nel suo tentativo disperato di andare oltre il tempo pur rimanendo confitto al suo interno e pur accettandone le leggi di funzionamento non revocabili e non capovolgibili per pura forza e virtù di volontà. Aggrapparsi all’alfa per raggiungere l’omega è l’aspirazione del poeta per il quale le parole della sua scrittura cercano di sfondare il limite che le costituiscono (e le costruiscono costantemente), ma sono poi alla fine la sola verità cui possono attingere e cui possono delegare le loro anelanti incertezze, la loro costrizione nella radura del finito che ricompone i tempi della vita umana. Il discorso poetico di Seghetta si dispiega in un ambizioso disegno di liricità musicale che coglie gli aspetti più significativi della navigazione chiamata vita. Non è un caso che la seconda sezione del volume si intitoli Di flauto e tamburo risuona il dolore e l’ultima delle sue sei parti evochi la forza di una voce che continua a echeggiare «nei chiostri di pietra» anche se in essi poi, alla fine, «si inabissa». Quella di Seghetta è pur sempre desiderosa assonanza di liricità ricongiunta all’originaria vocazione della poesia: il canto che si spezza sulle volte di pietra del dolore, lo scatto musicale che si trasfonde in parola, la necessità di molcire il dolore rendendolo capace di attraversare tutte le spettanze del vivere descrivendole e trasfigurandole in un’atmosfera di sogno. La «secca armonia» del verso scandisce il passaggio della vita e lo rende fitto di rumori dolci e aspri nello stesso tempo. Il passaggio della morte («il ritmo marziale di provati soldati») lo conturba. Eppure, nonostante la possibilità del male e del dolore, la bellezza del mondo si colora dell’attesa di una possibile salvezza che verrà dal fuoco della vita. Il «dolore» si addolcisce nel momento in cui l’armonia dell’esistenza si manifesta con il suo suono privilegiato che, per quanto voglia essere secco e aspro e severo, è pur sempre la testimonianza della verità di un’esistenza che conosce la bellezza dei «crochi» e delle «primule». Il «flauto e tamburo» della poesia si armonizza in un disegno che contiene in sé l’esorcismo del dolore e della morte perché, pur alimentandosi di essi, li brucia e li colora del segno rosso del coraggio di vivere. Attraverso di esso, il «dolore di padre» si conforta della gioia dell’aver dato la vita e la salva dal nero assoluto della mancanza, dalla fine della continuità tra le generazioni, della paura di esistere che la sofferenza e la morte sempre comportano. Nonostante il ritorno costante e la presenza ineliminabile del dolore del mondo come la difficoltà a trovare una ragione effettiva del suo sussistere inalterabile e assurdo, la ricerca di Seghetta si configura, anche in questo caso, proprio per l’aspirazione alla sua decisa volontà di ricongiungersi a un infinito che è possibile individuare come progettualità lirica, quale poesia della speranza. Nella sua ambizione di essere alfa e omega della vita e nella sua accertata imperfezione come sostanza dell’esistenza, la scrittura lirica gioca un ruolo fondamentale di armonizzazione dei contrasti e delle contraddizioni: scrivere, per Seghetta Andreoli, corrisponde a vivere e riuscire a capire (o almeno a provarsi a farlo) il perché negli «occhi del poeta» sia possibile leggere l’orrore del mondo ma anche il sogno della sua negazione. Attraverso la pratica della poesia, la morte non si annulla né si dimentica ma viene ricondotta entro i suoi limiti naturali dove tutto rinnova il filo rosso della propria continuità. Infinito come aspirazione e speranza di salvezza si ritrovano, allora, in un disegno che permette al desiderio di essere ricondotto alla sua natura di inquietudine e di allusione a qual-cos’altro che forse non è dato conoscere ma che costituisce la sostanza dei sogni degli uomini. Il «fiore del cardo» forte e aspro, pungente e spesso poco attraente, ma capace di durare e di resistere nel tempo e nelle avversità ne sarà sicuramente il simbolo araldico.
Introduzione