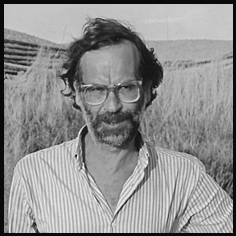
Alessandro
RICCI
Alessandro Ricci è nato a Garessio, in provincia di Cuneo, nel 1943 ed è scomparso a Roma nel 2004. Le sue raccolte di poesia: Le segnalazioni mediante i fuochi (Piovan, 1985, prefzione di Roberto Pazzi), Indagini sul crollo (Edizioni del Leone, 1989, prefazione di Roberto Pazzi), I cavalli del nemico (Il Labirinto, 2004), L’arpa romana (Il Labirinto, 2008, a cura di Francesco Dalessandro), L’editto finale (Il Labirinto, 2014, a cura di Francesco Dalessandro), I colloqui di Elpinti (antologia, Coup d’idée, 2015, con un saggio di Stefano Agosti), Tutte le poesie (Interlinea, 2019). Come sceneggiatore, ha collaborato alla realizzazione del film di Vittorio De Seta Il diario di un maestro; ha scritto soggetti e sceneggiature per cinema e televisione (alcune, con Claudio Bondì, raccolte in volume col titolo La storia a misura d’uomo sono pubblicate dalla ERI). L’ultimo film scritto (ancora con Claudio Bondì, che lo ha diretto) è stato De Reditu – Il ritorno, dall’omonimo poemetto di Rutilio Namaziano.
http://www.leuche.it/wp/wp-content/uploads/2017/04/Temperare-la-punta-alla-morte.pdf
http://poesia.blog.rainews.it/2015/05/in-memoria-di-te-alessandro-ricci/
POESIE
La primavera di Manarola
Perché spettacolare e golosa
è la gioia, io pranzavo
da solo sul molo. Alla cameriera
avevo ordinato una razione
e mezzo d’ogni portata. Arrivare
a me dalla cucina era
più pesante e più lungo. Altri
clienti non c’erano, ma
c’erano stati, tutti al chiuso
della veranda. Invece il mio
tavolo un palco, con l’acqua
verde ai due lati, e il mare
aperto davanti.
——————Bevevo molto,
volevo la stazza e la barba
bianca di Hemingway, il suo
guardare in lontani luoghi
perfetti.
———-Era un pomeriggio
bellissimo. Dal paese alle
spalle calavano, come gabbiani
ammodo, intermezzi in dialetto
che si posavano sulla pasqua.
Un gozzo quatto di un nero
caloroso scoppiettava in folle
tagliando alla deriva
una corrente più chiara,
pianissimo.
Io ero giovane, congedato
quella mattina, in divisa
primaverile, andando
al mio paese del nord.
Lo sapevo che il padre
non avrebbe resistito al suo
male, che Milva era persa e io
stanco e provato. E che da lì
forse da quel minuto,
sarebbe cominciato
il difficile.
————Ma due nuvole
del Piemonte, grasse come
chiocce, remavano lentamente
cupole senza chiesa, di un
bianco che s’allentava,
ivi sostando.
– Abbi pazienza, riposa
tu pure.
Chiudendo gli occhi
rivolti al sole, cangiavo
visioni cieche di rossi,
di aranci, di viola,
ma speravo nell’iniziata
ai Misteri, la bionda che
si pettina e guarda,
fissamente dentro
di te.
In quei mesi avevo appreso
l’angoscia e l’impossibilità
di esprimerla, atteso
la primavera sui tetti,
il ritorno delle rondini
e le parole alla bocca. Leggevo
molto, ma più il variare
della luce sulla tinta
ocra dei vecchi muri, lo
scaldarsi degli impiantiti
e delle dita che
li toccavano, giorno
dopo giorno.
Anche i versi di Eliot
e Pound parevano reticoli
galvanici sulle pagine,
perché in fine il libro
era caldo.
Tutto saliva, evaporava.
Perciò vivevo sui terrazzi,
sui poggi, sulle forre e,
quando non era possibile,
marciavo con la testa per
aria, a fiutare quell’intero
ascendere.
————-Mai stagione m’era
cosi teneramente nata.
Ora lì, dove su un molo riamavo
il vinello giallo, le bottiglie
vuote, la donna mancante,
le solitudini del futuro, tracciavo
sulla tovaglia di carta, non
come Esenin col sangue
alla morte, ma col sugo
di vongole sussurri alla vita.
Sognavo intessiture di sguardi,
linee d’oro alle nuche,
spalle leggere;
e l’invenzione degli occhi
di un’altra, la nuova innamorata,
più spesso vaniva nel nulla,
parlava inglese, moriva greca
all’orizzonte su cui
il sole
aveva tempo di declinare.
Non so come la cameriera
reggesse a portar vino
e io a berlo. Di certo,
non mi ubriacai.
Ero una boa azzurra.
Parlavo solo, dicevo
frasi d’amore
che non ricordo. Vennero
due bambini, quasi gemelli,
sicuramente fratelli, che
restarono vicino il tempo
delle parole e quello
dell’eco.
———-Riapparvero
più distanti, a far capolino
da una barca tirata in secco,
piena di funi attorte.
Poi più nient’altro
che la tregua,
un silenzio ammarato, una memoria
non colpevole di ginestre,
di attese, di sponde,
di velieri, di arrivi
e partenze, di odori
mescolati o distinti, che un
po’ erano lì, un po’ erano là,
o prima.
*
Arrivo dove nessuno mi aspetta.
Un dio no di certo, anche se
ci vorrebbe.
Mi aspettano la città di mio
padre e lunghe passeggiate
con lui che è morto.
Qualcuno ma non il cane, fin
troppo spiritualmente vissuto,
m’ha insegnato che bestia
sono.
Compro un collare e un guinzaglio
e mi faccio portare dal fantasma
del genitore nei vicoli
dell’infanzia, nell’erba
alta, o sul parapetto
di un ponte.
Ipotesi su Cavalcanti
I
Se ti fu concesso di tornare
a Firenze a morirvi, quello
non fu un viaggio da poco,
ma un termine di bellezze.
Era lucida la tua coscienza
di epicureo? di stoico
in ritardo? Quale dio
della fede pubblica che forse
s’era commossa per la tua
agonia fu nuovamente inutile
alla perpetua tristezza,
all’implacato andare
d’angelo doppio
in angelo persecutore fino
all’ultima pugnalata
che t’insegnò un’amara
pietà più per LEI
che per te, tanta
da non sopravviverle?
Forse in vista della città,
dopo molti odorosi colli, molti
cieli fra gli alberi solidali,
chiedesti alla scorta aiuto
con un filo di voce: per
scendere finalmente dal carro,
salire sul tuo cavallo
nell’estremo tratto
di brevità e dolcezza
entrando a Firenze;
con la testa alta e disfatta
di fantasma, perché un poco
agli astanti – fossero amici
o avversi – almeno
importasse l’aspetto fiero,
se non l’anima disperata.
II
E se non fosse a Sarzana né a Firenze,
ovvero in ogni
possibile luogo, in alto su una torre
o sotto un pergolato gravido d’uve
prossime alla vendemmia, qualche
amico e forse non
integerrime dame in digradanti sussurri
sulla sua sorte o la loro
poco distante, oppure
nessuno, magari uno spinone
avanti e indietro dal fogliame
a lui, o disteso sul lastrico divampante
ai suoi piedi, tra il sonno
e nella riconoscenza levando
il muso di tanto
in tanto, in cambio d’una carezza
o un’occhiata, e certo uccelli
di volo in volo:
girandole ritorni e fughe mai
di commiato, unici
a non saperlo, lui sì, come se in loro
fosse Mandetta o chiunque
riassunta in lei, prima e dopo la primissima
e forse l’ultima volta, a Tolosa
e dovunque, anno
dopo anno o ancora non
generato, se non lei,
lui?
—-E se non fosse là o altrove
che dopo averla letta
e riletta, corretti vocaboli
e enjambement, superàti lo scoglio
d’un settenario ostinato
e l’invadenza del cuore
sulla ragione, e di questa
su quello e riapparsi dentro
uno specchio bianchissimo
non vacillanti suoni
dell’ora e dello spazio
in cui tutto successe e niente
di nuovo sopravvenne a distrarne
la limpidezza, neppure le sue stesse
teorie, così lucide per rimatori
e filosofi, Guido capisse
che la ballatetta era compiuta e lui
con lei, e lei con LEI, tutti
in UNO, in quella fine
d’agosto?
I cavalli del nemico
Un dolore fermo, non acre, forse nel mezzo della corazza,
li aveva scartati tutti. Alcuni non gli parevano
sconosciuti. Al doppio segnale dell’ennesimo
attacco era sembrato inevitabile
scontrarsi un’altra volta
con loro, ma non era
successo. Di tre
o quattro
catafratti invece
ricordava chiara-
mente la furia e la destrezza nelle prime
fasi della battaglia, la velocità
delle fughe e i reiterati
assalti. E le ferite leggere
che gli avevano inferto: pochi graffi
quasi rimarginati, se non proprio
invisibili.
Uno dopo l’altro, li aveva osservati con attenzione.
La fila era stata lunga: di molte,
alte clessidre,
eppure erano le bestie
strappate ai vincitori.
Si chiese allora sgomento quanti cavalli del suo
esercito decimato fossero già nel campo persiano,
inadatto forse
a contenerli tutti, quanti nemici
li avrebbero ridomati, addolciti,
addestrati, infine caracollati
al decisivo assalto, al disastro,
al macello finale.
La filza degli animali catturati, ben più umani
dei pochi prigionieri così meno afflitti,
sembrava finita.
Nel vuoto dopo l’ultimo scalpiccìo,
apparvero nella pianura gialli e sfocati roghi
molto, molto lontani. E s’udirono,
ma non appena, strazi e lamenti:
dei piagati, dei moribondi e,
come un’eco,
dei morti.
Così tramontava quella giornata terribile.
Quanto male, misto a quel sordo
vuoto nel petto,
s’accaniva con l’impazienza.
Fu dal buio che s’allargava, a un’irruzione di gelo nel ritardo,
quando emersero i due mancanti: erano stati loro, più loro
di chi li aveva montati, a colpirlo nel petto,
e vide finalmente l’asta a due punte
che l’aveva trafitto:
il primo era un cavallo chiaro, morbido e triste, quasi
luttuoso. L’accompagnava, serpeggiandogli fra le zampe,
un gatto vecchio e ostinato: nella bocca sdentata,
in una presa insicura, la carogna d’un ratto
troppo grosso, ridotta a poltiglia
sanguinolenta.
—————–Poi l’altro: un puledro aspro e impaziente,
avido ancora di zuffa, cui s’accodava, a distanza,
a fatica, forse per caso, un bianco
cane tremante.
L’explorator
Primo sulla collina di Sèffos,
vide l’altro versante pieno di Parti.
– Quadrato stavolta ha sbagliato
di grosso, non era qui che dovevamo
passare. Ci faranno a pezzi prima
di sera. Noi, i Romani, i padroni
del mondo.
Si voltò a guardare la coorte,
la migliore della legione: silenziosa
e composta, s’avvicinava alla cima.
————–Non fischiò
il pericolo ai suoi come avrebbe
dovuto. Si distese a guardare
una nuvola lentamente fra i rami,
tanto era troppo tardi.
Accampamento di fine impero
A Vindonissa d’Elvezia
il centurione Gaviso passa
in rassegna le vene del polso
per trafiggerle col pugnale.
(Un mercenario vandalo
porterà il mastello
con l’acqua calda
e le tavolette del testamento).
Esce intanto a guardare
Vindonissa immune
dalla tragedia.
—————–Laggiù si leva
il fumo delle colazioni
dalle capanne indigene,
si mescola al presagio
che pioverà fra i pini
anche oggi.
Al riparo dello steccato,
gli ausiliari giocano ai dadi.
I cani della legione
si contendono le molliche,
ma non è come sempre.
Nel tabernacolo
i comandanti concludono
che l’anima non sopravvive,
guardando fisso davanti a sé.
Le sentinelle hanno portato
birra sulle torri di legno:
la cavalleria alla fine
del turno inviterà i fanti
a mangiare i cavalli.
Le puttane siriache
al seguito dell’esercito
guidano personalmente
il carro fuori del campo,
colmo di doni.
—————–Fuggono solo
loro, ché sanno vivere.
Gaviso infatti
non ha più niente
da ricordare, e ritorna
alla tenda.
————-Domani i Germani
romperanno da oriente
